Eristica
L’eristica è l’arte di vincere la disputa verbale, indipendentemente dalla verità dell’argomentazione sostenuta.
A differenza della dialettica filosofica, che mira alla verità, l’eristica mira alla confutazione dell’avversario, spesso tramite giochi di parole, equivoci logici e retorica manipolativa.
E' l'arte della controversia finalizzata all’obiettivo di far prevalere la propria tesi, vera o falsa che sia. In breve: vince chi sa parlare meglio, non chi ha ragione.
Origine: l’eristica come figlia del relativismo sofista
L’eristica nasce all’interno della sofistica, come suo esito estremo. I sofisti, fin dalle origini, difendono una concezione relativista della verità.
Secondo Protagora, “l’uomo è misura di tutte le cose”: ciò che appare vero per qualcuno, lo è davvero per lui.
Questo rende possibile difendere qualsiasi tesi, anche la più assurda, purché argomentata bene. Se a ogni proposizione è possibile contrapporre quella contraria... allora è possibile confutare qualsiasi asserto.
Da qui si sviluppa l’idea che non esistano verità assolute, ma solo punti di vista: nasce il terreno fertile per l’eristica.
Involuzione: dalla paideia alla pura tecnica
Con l’eristica, la sofistica perde ogni funzione educativa. Non si tratta più di formare il cittadino attraverso l’arte della parola, ma di insegnare come sconfiggere l’avversario con ogni mezzo dialettico disponibile.
La sofistica perde ogni spessore filosofico e si riduce solo a pura arte dialettica e confutatoria»*
L’insegnamento sofistico diventa un’istruzione al combattimento verbale, dove l’argomento migliore è quello che fa tacere l’altro, non quello che si avvicina di più al vero.
Gli strumenti dell’erista: dilemma, sofisma, ambiguità
Gli eristi impiegano strumenti formali e strategici per confondere:
- Il dilemma: una domanda costruita in modo da rendere l’interlocutore perdente qualunque sia la risposta.
- Il sofisma: un ragionamento logicamente fallace, ma strutturato in modo da sembrare corretto.
- L’ambiguità linguistica: sfruttare l’equivoco dei termini per manipolare le risposte.
Ad esempio, "Tu sai ciò che non hai perso. Non hai perso le corna. Quindi hai le corna." Il paradosso non cerca verità, cerca imbarazzo e disorientamento logico.
La critica filosofica: Platone e il caso di Eutidemo
Platone è il principale oppositore dell’eristica. Nel dialogo *Eutidemo, presenta i due fratelli sofisti Eutidemo e Dionisodoro: maestri nell’arte di dire tutto e il contrario di tutto con apparente rigore.
Per Platone, questi filosofi non cercano il sapere ma solo l’applauso. La loro retorica è vuota, insincera, dannosa.
L’eristica, secondo Platone, è solo una caricatura del vero dialogo socratico: dove la maieutica cerca la verità, l’erista cerca solo la vittoria.
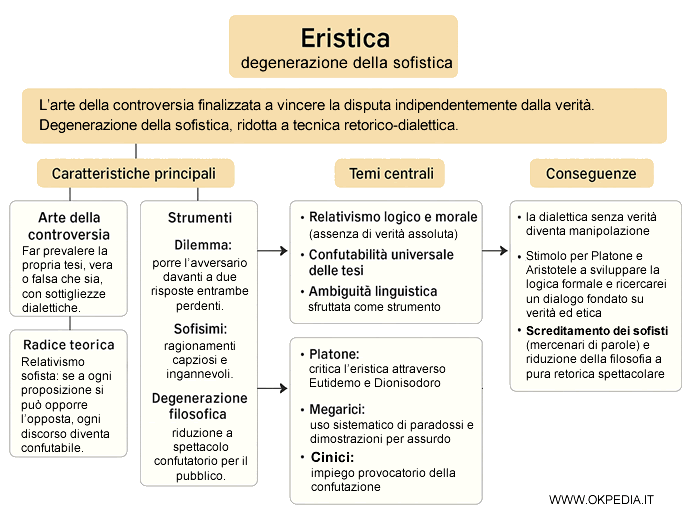
Le conseguenze: il declino dell’immagine sofistica
L’abuso dell’eristica comporta una progressiva perdita di credibilità dell’intera tradizione sofistica.
I sofisti, originariamente impegnati nell’educazione civica attraverso la parola, finiscono per essere percepiti come mercenari della parola, esperti nell’arte di persuadere senza fondamento, venditori di tecniche dialettiche prive di contenuto etico.
Alcune scuole filosofiche successive, come i megarici e i cinici, riutilizzarono strumenti eristici, ma con finalità differenti:
- i megarici, per mettere in crisi le strutture logiche del linguaggio attraverso paradossi e sofismi;
- i cinici, per denunciare la vacuità delle convenzioni sociali, ricorrendo alla provocazione verbale.
Tuttavia, in entrambi i casi, l’uso della parola si allontana dalla ricerca della verità e si trasforma in strumento di rottura o di sfida.
L’eristica diventa così emblema di una parola senza fondamento, che non informa, non educa e non chiarisce, ma smonta, confonde, destabilizza.
Nota. In questa prospettiva, la degenerazione della sofistica in eristica non è solo un fatto storico: è anche un problema teorico. Quando la parola non è più al servizio della verità, ma della vittoria, della confutazione o dell’effetto, che cosa resta del pensiero? Una tecnica senza verità si riduce a manipolazione. Un’argomentazione senza criterio oggettivo non è dialogo, ma rumore travestito da ragione.
